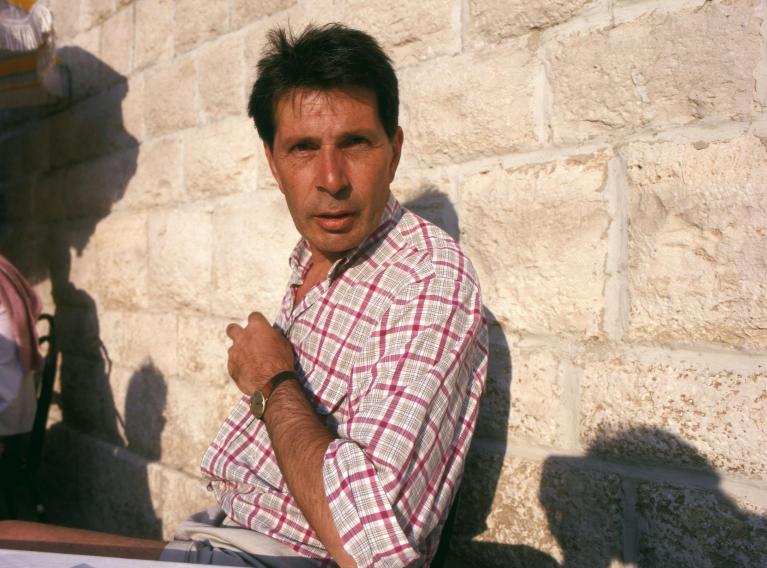Daniele Benati – 13 Agosto 2019
Nell’autunno dell’84 mi trovavo a Dublino con una borsa di studio per svolgere una ricerca sulle opere di Flann O’Brien, un autore che avevo scoperto da poco ma che mi aveva messo addosso una gran voglia di andare in Irlanda. Da tempo non ero più uno studente e avevo già avuto diverse esperienze di lavoro che poco o nulla c’entravano con quello che avevo studiato all’università, cioè la letteratura inglese e americana. Ma l’impatto della lettura di O’Brien — del suo romanzo At Swim-Two-Birds, tradotto in italiano col titolo bellissimo di Una pinta di inchiostro irlandese — era stato così forte da indurmi a lasciare la mia situazione di lavoro in Italia, peraltro precaria, per cercare di andare in Irlanda, cosa che poi mi sarebbe riuscita grazie a una borsa di studio assegnatami dal Ministero degli esteri della durata di 8 mesi presso il Trinity College di Dublino sotto la guida della professoressa Anne Clissmann, considerata a quel tempo la massima esperta di Flann O’Brien.
A Dublino, poi, avevo cercato fin da subito di approfondire la mia conoscenza delle opere di O’Brien, soprattutto del suo romanzo The Poor Mouth che avevo scoperto essere una parodia delle narrazioni autobiografiche dei vecchi narratori gaelici delle zone rurali e sperdute dell’Irlanda occidentale, come Thomas O’Crohan e Peig Sayers. E subito, dato che di quel libro non esisteva una versione in italiano, avevo pensato che un tentativo avrei potuto farlo io, di tradurlo, naturalmente senza sapere a quali difficoltà sarei andato incontro. Io avevo letto la versione inglese del romanzo ed ero rimasto colpito dalle frequenti ricorrenze nel testo di astrusi costrutti sintattici o di cliché linguistici che con l’inglese standard mi sembrava avessero ben poco a che fare e che mi facevano pensare che in italiano avrei potuto risolverli tramite l’assunzione di forme analoghe che erano individuabili nel mio dialetto. L’idea in sé poteva esser giusta ma alla lunga forse una soluzione del genere più che presentarsi come un tratto stilistico avrebbe potuto generare un effetto di sciatteria. Così mi era venuto in mente di prendere come possibile modello a cui ispirarmi la lingua di un romanzo che avevo letto dieci anni prima, quando ero al mio primo anno di università. Un libro che, similmente, mi aveva colpito per il modo strambo in cui era stato scritto e per le stramberie che vi erano raccontate. E questo libro era Le avventure di Guizzardi di Gianni Celati.
Devo aprire una breve parentesi. Io questo libro lo avevo letto a pezzi e bocconi durante le soste che facevo alla libreria Feltrinelli sotto le due Torri, a Bologna, prima di andare in stazione per prendere il treno per tornare a casa mia, a Reggio, dopo aver seguito le lezioni all’università. E lo avevo preso in mano la prima volta da un’alta pila — dato che era appena uscito — perché attratto dalla foto del comico americano Harry Langdon che compariva in copertina, colto in una delle sue solite espressioni di disappunto. Poi avevo cominciato a leggerlo e quello che leggevo mi sembrava tutto scritto in maniera sballata, se non addirittura sgrammaticata, e certamente anomala rispetto al modo in cui erano scritti i romanzi che dovevo studiare per i miei corsi, ma anche molto originale.
Naturalmente all’epoca ero bel lontano dal capire il tipo di lavoro che Celati aveva fatto in quel libro,ma non tanto da non rendermi conto che in quel libro c’era qualcosa d’importante da capire, così come c’era nel suo autore. E così mi ero informato su di lui, mi ero incuriosito, un giorno ero anche andato a una sua lezione, nonostante insegnasse in un corso di laurea diverso da quello a cui ero iscritto io — una lezione su Mark Twain. E poi negli anni successivi avevo continuato a seguirlo, ma da lontano, imparando cose per sentito dire, o tramite persone che lo conoscevano; fino a quando, un anno prima che io venissi qui in Irlanda, avevo cercato di contattarlo per chiedergli se potevo fargli avere un testo narrativo che avevo scritto e di cui mi interessava sapere il suo parere — ma questa è un’altra storia.
Qui a Dublino, dunque, avevo ripreso in mano il suo libro Le avventure di Guizzardi, di cui avevo trovato una copia alla biblioteca del Trinity, e me lo ero riletto tutto da cima a fondo per accordare il mio orecchio al suono della sua lingua e cercando di individuarne i meccanismi stilistici più curiosi e replicabili, in modo da poterli inserire riadattandoli nella mia traduzione di The Poor Mouth.
Ma a parte questo, e a prescindere dalla mia traduzione, il punto del mio discorso è che, pure a distanza di tanti anni, Guizzardi è ancora oggi un testo che sorprende per l’infinita varietà delle sue invenzioni linguistiche e quella che a tutta prima potrebbe sembrare — come era sembrato a me — una prosa un po’ sballata, in realtà è il frutto di una sofisticatissima operazione letteraria ed è costituita da un fraseggio modellato su un andamento sintattico non convenzionale e contraddistinto da inversioni tipiche più del linguaggio poetico che non di quello narrativo, nonché da certi espedienti ritmici che tentano di riprodurre sul piano della scrittura gli stessi effetti che si ottengono in campo musicale, ad esempio nel jazz, tramite l’uso del cosiddetto tempo sincopato.